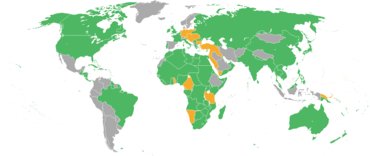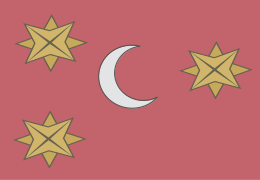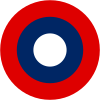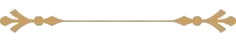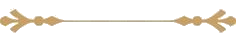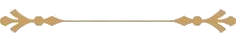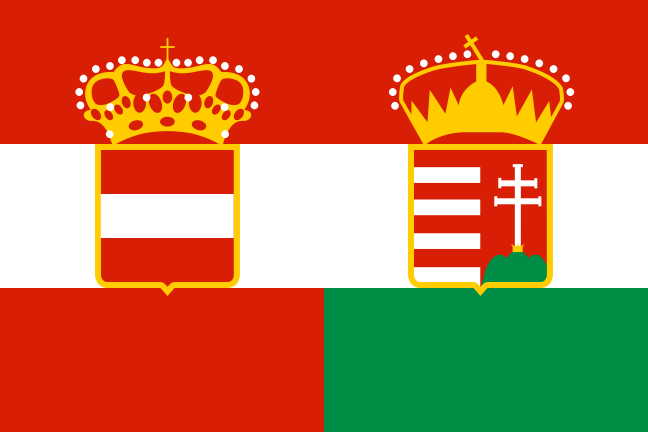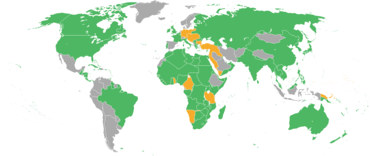
Gli Alleati della prima guerra mondiale furono quei paesi che, aggiungendosi alle potenze della Triplice Intesa (Impero britannico, Francia e Impero russo), formarono durante il primo conflitto mondiale una coalizione contro gli Imperi centrali (Impero tedesco e Impero austro-ungarico); in particolare, alle potenze dell’Intesa si aggiunsero l’Impero Giapponese nel 1914, il Regno d’Italia nel 1915 e gli Stati Uniti d’America nel 1917, mentre alla fine del 1917 la Russia, stremata dalla guerra e caduta preda della rivoluzione d’ottobre, abbandonava l’alleanza.
Dopo l’assassinio di Francesco Ferdinando

Serbia
28 luglio 1914

Impero russo
1º agosto 1914 (pace separata il 3 marzo 1918)

Francia
3 agosto 1914

Belgio
4 agosto 1914

Impero britannico
4 agosto 1914

Montenegro
8 agosto 1914

Giappone
23 agosto 1914
Dopo la prima battaglia della Marna

Regno d’Italia
24 maggio 1915

Emirato del Najd e di al-Ahsa’
26 dicembre 1915

Portogallo
9 marzo 1916

Regno di Romania
27 agosto 1916 (pace separata il 7 maggio 1918 e di nuovo in guerra il 10 novembre 1918)
Dopo la caduta dell’Impero russo

Stati Uniti
6 aprile 1917

Regno di Grecia
2 luglio 1917

Siam
22 luglio 1917

Brasile
26 ottobre 1917
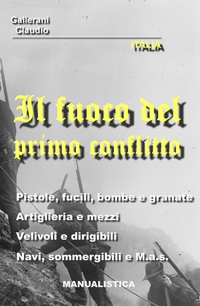
Libri: Il fuoco del primo conflitto
VEDI ANCHE: Eserciti e flotte della prima guerra mondiale