S:2-Ep:48
Gabriele D’Annunzio NON è una persona qualunque.

Nell’episodio precedente abbiamo parlato dell’infanzia del Vate e, principalmente, del suo periodo legato alla prima guerra mondiale, ma va da sé che una sola puntata non avrebbe mai reso pienamente onore a Gabriele D’Annunzio, quel Gabriele che non si accontentò del termine del conflitto ma che lo mosse verso quella che rimase impressa nei libri di storia come l’impresa di Fiume.
Nel settembre 1919 d’Annunzio, alleatosi con un gruppo paramilitare, guidò una spedizione di “legionari” per l’occupazione della città di Fiume, che le potenze alleate vincitrici non avevano assegnato all’Italia.
Con questo gesto D’Annunzio raggiunse l’apice del processo di edificazione del proprio mito personale e politico perché a Fiume, occupata dalle truppe alleate, già nell’ottobre 1918 si era costituito un Consiglio nazionale che propugnava l’annessione all’Italia, di cui fu nominato presidente Antonio Grossich.
D’Annunzio con una colonna di volontari, tra i quali vi era anche Silvio Montanarella, marito della figlia Renata, occupò Fiume e vi instaurò il “Comando dell’Esercito italiano in Fiume d’Italia” e dove il 5 ottobre 1920 aderì al Fascio di combattimento di Fiume.
D’Annunzio, che era anche comandante delle Forze armate fiumane, e il suo governo vararono tra l’altro la Carta del Carnaro, una costituzione provvisoria, scritta dal sindacalista rivoluzionario Alceste de Ambris e modificata in parte da D’Annunzio stesso, che prevedeva numerosi diritti per i lavoratori, le pensioni di invalidità, l’habeas corpus, il suffragio universale maschile e femminile, la libertà di opinione, di religione e di orientamento sessuale, la depenalizzazione dell’omosessualità, del nudismo e dell’uso di droga, la funzione sociale della proprietà privata, il corporativismo, le autonomie locali e il risarcimento degli errori giudiziari, il tutto molto tempo prima di altre carte costituzionali dell’epoca.
Alle nove corporazioni originarie ne aggiunse una decima, costituita dai cosiddetti “uomini novissimi”, gli articoli 503 e 504 delineano la figura di un “Comandante”, lo stesso D’Annunzio, eletto con voto palese, una sorta di dittatore romano, attivo per il tempo di guerra, che detiene “la potestà suprema senza appellazione” e “assomma tutti i poteri politici e militari, legislativi ed esecutivi. I partecipi del Potere esecutivo assumono presso di lui officio di segretari e commissari.
Alcuni sostengono che D’Annunzio avesse usato mezzi repressivi per il governo di Fiume, i quali precorsero quelli poi usati dai fascisti, è diffusa l’opinione che l’uso dell’olio di ricino come strumento di tortura e punizione dei dissidenti sia stato introdotto proprio dai legionari di D’Annunzio, poi fatto proprio e reso famoso dallo squadrismo fascista.
Altri sostengono invece che l’esperienza non ebbe connotati solo nazionalistici, ma anche liberali e libertari piuttosto netti, e che il poeta non avesse intenzione di costituire un governo personale, ma solo un governo d’emergenza con possibilità di sperimentazione di diverse idee, aggregate in un programma politico unico grazie al suo carisma.
D’Annunzio, per un certo periodo, guardò con curiosità ai bolscevichi, tanto che il 27 e il 28 maggio 1922 ospitò al Vittoriale Georgij Vasil’jevič Čičerin, commissario sovietico agli affari esteri arrivato in Italia per la conferenza di Genova, tuttavia nel 1926 esprimerà invece critiche contro il governo sovietico.
Il 12 novembre 1920 i governi italiano e jugoslavo stipularono il trattato di Rapallo, che trasformava Fiume in una città libera, D’Annunzio non accettò il trattato e rifiutò ogni mediazione, spingendo il governo a intervenire con la forza.
Tra il 24 e il 27 dicembre, le truppe governative attaccarono i legionari, la breve guerra, definita Natale di sangue, causò numerosi morti e il bombardamento della città.
Ai tempi di Fiume D’Annunzio soprannominò sprezzantemente Cagoja l’ex primo ministro Francesco Saverio Nitti e lo Stato libero di Fiume non ebbe vita facile, anche dopo la partenza di d’Annunzio, fu sconvolto dal conflitto tra autonomisti e annessionisti, fino a quando nel 1924 la città fu annessa dall’Italia fascista.
Deluso dall’epilogo dell’esperienza di Fiume, nel febbraio 1921 si ritirò in un’esistenza solitaria nella villa di Cargnacco, nel comune di Gardone Riviera, che pochi mesi più tardi acquistò.
Ribattezzata il Vittoriale degli Italiani, fu ampliata e successivamente aperta al pubblico, qui lavorò e visse fino alla morte, curando con gusto teatrale un mausoleo di ricordi e di simboli mitologici di cui la sua stessa persona costituiva il momento di attrazione centrale.
D’Annunzio si impegnò inoltre per la crescita e il miglioramento della zona: la costruzione della strada litoranea Gargnano-Riva del Garda del 1929-1931 fu fortemente voluta da lui, che se ne interessò personalmente, facendo valere il suo prestigio personale con le autorità.
La strada, progettata e realizzata dall’ing. Riccardo Cozzaglio, segnò il termine del secolare isolamento di alcuni paesi del lago di Garda e fu poi classificata di interesse nazionale con il nome di Strada statale 45 bis Gardesana Occidentale.
Lo stesso D’Annunzio, presente all’inaugurazione della strada, la battezzò con il nome di Meandro, per via della sua tortuosità e dell’alternarsi delle buie gallerie e del lago azzurro.
Promosse attività sportive tra cui la motonautica e gare idro-aviatorie: tra queste la Coppa del Benaco lanciata da Gabriele D’Annunzio con l’appello da lui composto, il poema Per la coppa del Benaco, del 21 agosto e disputata il 24 settembre 1921 a Gardone Riviera.
Per l’occasione il poeta donò una coppa d’argento, opera dello scultore Renato Brozzi, dedicata alla memoria dei compagni volatori caduti.
Altro evento motonautico patrocinato da d’Annunzio fu, nel giugno 1931, il Meeting Internazionale di Motonautica, il Garda divenne, soprattutto per l’affascinante richiamo dannunziano, la palestra dei più grandi campioni del mondo, fra i quali l’inglese Henry Segrave.
Il rapporto con il fascismo è oggetto di un dibattito complesso tra gli storici, il fascismo celebrò sempre D’Annunzio come un suo precursore politico e letterario, lo scrittore, dopo un’adesione iniziale ai Fasci italiani di combattimento, non prese mai la tessera del Partito Nazionale Fascista, probabilmente per mantenere la sua autonomia.
Nel 1919 Mussolini avviò tramite il suo quotidiano Il Popolo d’Italia una sottoscrizione pubblica per finanziare l’Impresa di Fiume, con la quale raccolse quasi tre milioni di lire, una prima tranche di denaro, ammontante a 857 842 lire, fu consegnata a D’Annunzio ai primi di ottobre, mentre altro denaro gli giunse in seguito.
Una parte cospicua del denaro raccolto, però, non fu consegnata a D’Annunzio e Mussolini fu accusato da due redattori di averla dirottata per finanziare lo squadrismo e il proprio partito in vista delle vicine elezioni politiche italiane del 1919.
Per controbattere alle accuse, D’Annunzio inviò una lettera a Mussolini in cui ne attestò pubblicamente l’autorizzazione, il poeta certificò che parte della somma raccolta era stata utilizzata per finanziare lo squadrismo a Milano.
Nel 1937 fu eletto Presidente dell’Accademia d’Italia, ma non andò mai a presiedere alcuna riunione, la nomina fu quasi imposta da Benito Mussolini, con la contrarietà di D’Annunzio, fu anche Presidente onorario della SIAE dal 1920 al 1938.
Per molti il Duce, temendo la popolarità e la personalità indipendente del poeta, tentò di metterlo risolutamente da parte, ricoprendolo di onori, Mussolini arrivò a finanziarlo con un assegno statale regolare, che gli permise di far fronte ai numerosi debiti; in cambio D’Annunzio evitò di esternare troppo il disprezzo che provava per la trasformazione del fascismo-movimento, che aveva ammirato, in un regime dittatoriale.
Di certo vi era la scomodità del personaggio: già nel 1922, tre mesi prima della Marcia su Roma, quando D’Annunzio cadde dalla finestra della sua villa rischiando la vita, vicenda soprannominata “il volo dell’arcangelo”, qualcuno parlò di un attentato ordito dal primo ministro Francesco Saverio Nitti o addirittura dai fascisti; il funzionario Giuseppe Dosi indagò sulla caduta “accidentale” di D’Annunzio, che quasi ne provocò la morte, ma dedusse, a torto o per convenienza, che il fascismo non vi fosse implicato, almeno in questa occasione.
D’Annunzio fu posto poi sotto il controllo di agenti fascisti, visti anche i buoni rapporti del Vate con esponenti del mondo libertario, socialista e rivoluzionario, tra cui l’ex legionario fiumano e poi socialista Alceste de Ambris e il politico Aldo Finzi, fascista di sinistra, poi partigiano antifascista che prese parte con il poeta al volo su Vienna.
Nel 1937-38 D’Annunzio si oppose all’avvicinamento dell’Italia fascista al regime nazista, bollando Adolf Hitler, già nel giugno 1934, come “pagliaccio feroce”, “marrano dall’ignobile faccia offuscata sotto gli indelebili schizzi della tinta di calce di colla”, “ridicolo Nibelungo truccato alla Charlot”, “Attila imbianchino”.
A partire da questo periodo, D’Annunzio cominciò a propagandare la necessità di completare l’irredentismo con una nuova “impresa fiumana” sulla Dalmazia, Mussolini e Starace lo fecero mettere segretamente sotto stretta sorveglianza, non fidandosi di lui e delle sue iniziative.
D’Annunzio, fotofobico in seguito all’incidente all’occhio del 1916, stava comunque spesso nella penombra, coprendo con tende le finestre esposte alla luce solare diretta, faceva spesso uso di stimolanti, come la cocaina, medicinali vari e antidolorifici.
Il 1º marzo 1938, alle ore 20:05, Gabriele D’Annunzio morì nella sua villa per un’emorragia cerebrale, mentre era al suo tavolo da lavoro; sullo scrittoio era aperto il Lunario Barbanera, con una frase da lui sottolineata di rosso, che annunciava la morte di una personalità.
Alla notizia della morte del poeta, Mussolini avrebbe detto di avvertire un senso di “vuoto” e che il Vate “aveva rappresentato molto nella sua vita”; parole che rientrano nel complesso rapporto Duce-Vate con il primo che faceva sorvegliare e definiva in privato il secondo “il vecchio bardo decrepito”.
Ma questa, è un’altra storia.
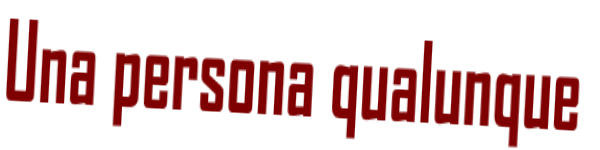
100 episodi del Podcast gratuito anche su Spotify.




